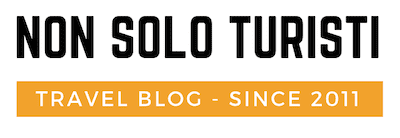Durante la mia breve permanenza al Cairo, ogni volta che uscivo con una meta in testa non riuscivo mai a raggiungerla. E forse è stato meglio così: la città è una di quelle che per scoprirle bisogna perdersi tra le vie e gli anfratti più reconditi, per poi ritrovarsi di fronte ad atmosfere da mille e una notte che non si sarebbero mai assaporate con un chiaro itinerario sotto i piedi.
Una mezza mattinata, a dire il vero, l’ho trascorsa al Museo Egizio: triste pilastro di antica memoria somigliante perlopiù a un vecchio magazzino dimesso, un pozzo apparentemente inesauribile di reminiscenze storiche abbandonate a sé stesse senza apparente cura né devozione. Le sale scarsamente illuminate, la polvere, l’infinità di reperti… non sapevo se essere affascinato dal decadente fascino di quel luogo o se lasciarmi intristire dalla misera gloria di cui era invaso.
Mi sono perso invece mentre giravo per Mari Girgis, il quartiere copto della città, e sono arrivato fino alla Corniche – la strada che affianca gli argini del Nilo – per poi attraversare il fiume sul ponte fino all’isoletta chiamata Roda. La città fluviale è un misto di fatiscente degrado e vegetazione rigogliosa, arbusti e alte frasche ricoprono palazzi “leopardati” a causa delle facciate segnate da collassi, incendi e umidità.
E mi sono nuovamente perso quando volevo arrivare a Al-Hazan Park, dalla cui collina avrei potuto ammirare il tramonto che scende sulla città. Sempre dritto, niente di più facile. Senza volerlo sono finito nel Quartiere Islamico – insolito appellativo per la capitale di una nazione completamente islamica – e ho finito per soppiantare il panorama con una serie di maestose moschee, mentre mi infilavo in viottoli malconci ma non privi di fascino. Devo dire che le moschee mi piacciono più delle piramidi: c’è sempre qualcosa di non detto nel fascino delle torri illuminate la sera, delle cupole di disneyana memoria e della calca di gente davanti alle botteghe che circondano le aree dedicate al culto.
Perdersi in fondo serve a ritrovarsi, a capire chi sei e dove stai andando. Quando hai rinunciato anche all’ultima speranza di ritrovare la strada tramite cartine imprecise e brandelli di informazione sei finalmente pronto a farti sorprendere dalla prossima tappa: ecco che a quel punto non esiste più una strada sbagliata, sono tutte giuste. Libero da ogni aspettativa, tutto quello che c’è davanti è scoperta e conoscenza. Il mio perdermi mi aveva ricordato che arrancavo quasi senza meta da quasi un anno, che non avevo spiaccicato una parola di italiano da almeno sei mesi, né in inglese da due. Che bramavo ardentemente un piatto di pasta e una pizza. Che non avevo più bevuto un bicchiere di vino da quando avevo lasciato il Sudafrica. Tutte cose su cui riflettere.
Cercavo di capire cosa mi sarei dovuto aspettare dalla conclusione del mio viaggio. Cominciavo a sentire la stanchezza, e il fatto di non avere nulla di intelligente da fare mi faceva sentire nel posto sbagliato ovunque mi trovassi. Come se non bastasse l’otturatore della mia macchina fotografica era andato a farsi benedire e senza la mia fedele Nikon mi sentivo nudo come un verme e inutile come la birra senz’alcol. Il fatto stesso che sempre più spesso mi fermassi a pensarci era un sintomo importante. Avevo bisogno di azione, così ho telefonato in Alessandria per prenotare una camera d’albergo e sono andato in Ramses Station a comprare un biglietto del treno.
Leggi la puntata precedente: al Cairo un anno dopo l’inizio della rivoluzione.
Vai alla prossima puntata: Alessandria, l’ultima tappa di un lungo viaggio.
Laureato in Giornalismo, il mio limbo professionale mi ha portato dagli uffici stampa alla carta stampata, per poi approdare al variopinto mondo della comunicazione digitale. Ho vissuto a Verona, Zurigo, Londra, Città del Capo, Mumbai e Casablanca. Odio volare, amo lo jodel e da grande voglio fare l’astronauta.